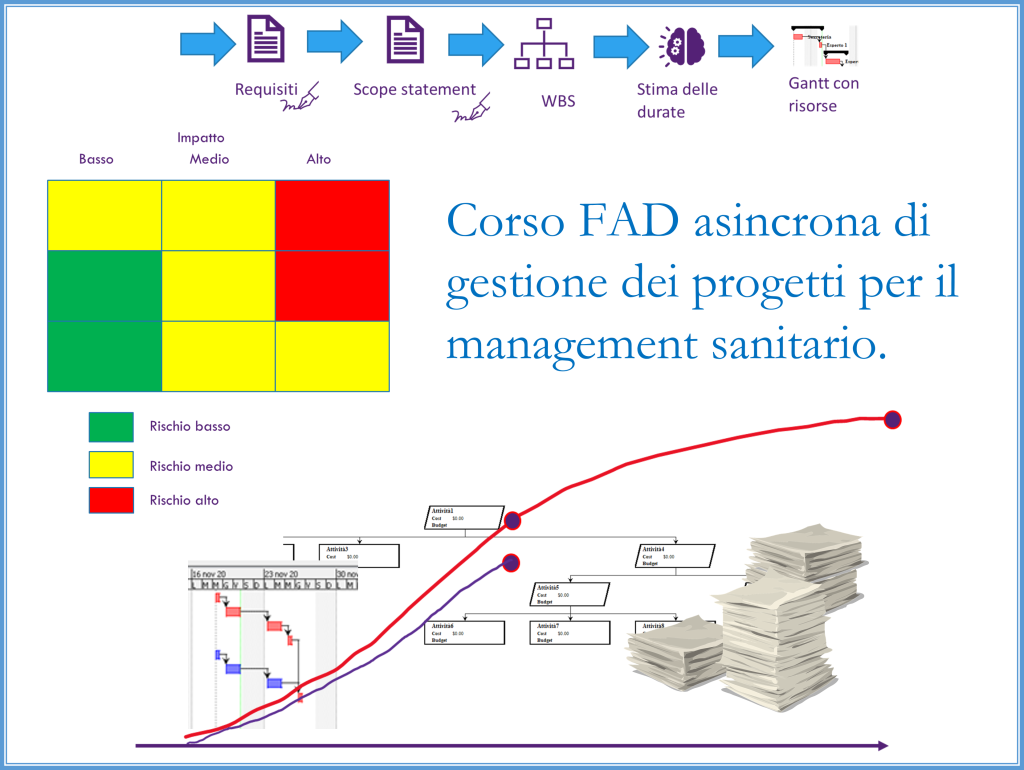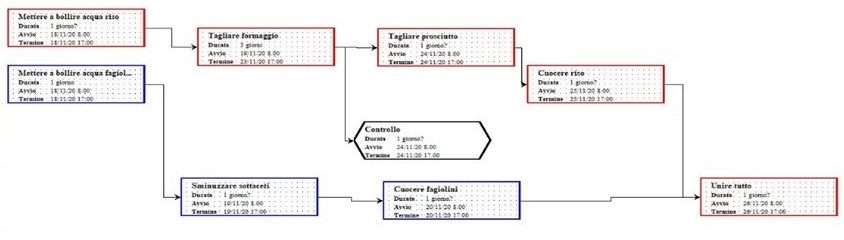Nel momento in cui dovessimo entrare a far parte di una nuova organizzazione, o se dovessimo trovarci, per qualsiasi motivo, ad osservarla dall’esterno, noteremmo subito dei comportamenti che ci potrebbero disorientare, divertire, irritare o addirittura incuriosire.
In poche parole sembrarci strani.
Lo sbigottimento è destinato a scemare man mano che il tempo passa, nel momento in cui, con estrema naturalezza, riuscissimo ad assimilare la cultura aziendale e ad adeguarci ad essa.
Ogni organizzazione infatti è caratterizzata da una sua cultura, molto specifica e molto privata.

Ma cos’è una cultura aziendale?
Le definizioni sono tante ma, nella sostanza, non molto diverse fra loro:
Un modo di pensare e di fare le cose.
(E. Jacques 1952)
Uno schema di assunti fondamentali che un gruppo ha inventato per affrontare e risolvere i problemi ….. assunti che sono ritenuti validi e quindi degni di essere insegnati ai nuovi membri.
(Schein 1985)
Le conoscenze che i membri di un certo gruppo condividono in misura maggiore o minore.
(Maanen 1988)
La cultura aziendale è un insieme di regole più o meno scritte, di modi di fare, di espressioni che vengono preferite al posto di altre, di miti che vengono trasmessi dai veterani ai nuovi arrivati.
Non è visibile di per sé, se si escludono gli artefatti (ad es. lo stile degli ambienti fisici come i colori, l’organizzazione degli spazi ecc.), ma si manifesta tramite il linguaggio ed il comportamento delle persone; per i nuovi membri, i princìpi insiti nella cultura aziendale vengono presentati come la meta alla quale tendere per appartenere realmente a quel contesto sociale.
E sappiamo bene quanto il senso di appartenenza sia fondamentale per lavorare bene, per sentirsi tranquilli.
Si tratta del lato psicologico dell’ingresso in un gruppo. È un bisogno naturale e per soddisfarlo dobbiamo adeguarci alle regole, ai princìpi, ai valori e ai comportamenti condivisi, tutti elementi della cultura aziendale. Allinearsi ad essa riduce l’ansia, riconduce tutto a situazioni comprensibili e gestibili, aumenta il senso di coesione.
D’altronde, quando entriamo in una nuova organizzazione, il nostro comportamento dovrebbe essere quello che adotteremmo entrando in casa d’altri, ossia di profondo rispetto delle regole. Saremmo pur disposti a metterci le pattine se ci venisse richiesto.
E se fossimo, per principio, contrari alle pattine e avessimo già condotto le nostre personalissime battaglie per tentare di eliminarle dal mercato?
Riflettiamo un attimo su come viene formata una cultura aziendale.
Essa ha origine internamente all’organizzazione e deriva soprattutto dal comportamento del top management. Ma è anche influenzata dai valori e dalle consuetudini che sono tipici dell’ambiente sociale in cui l’azienda è inserita; quest’ultimo permea tramite il bagaglio di esperienze passate e di convinzioni personali di ogni lavoratore, tramite le leggi, l’etica e i principi morali tipici della nazione in cui l’azienda opera.
Sappiamo inoltre che il nostro comportamento ed il nostro giudizio sono modellati da tutti i contesti in cui siamo, o siamo stati, inseriti: la famiglia, la scuola, la comunità, la religione, la politica, il circolo sportivo eccetera. Se ci pensate bene, ogni ambiente, oltre ad influenzarci, può essere influenzato da noi: è ovvio che ognuno di noi abbia, almeno una volta, agito in modo da rendere un contesto più vivibile, perlomeno dal proprio punto di vista. Dipende ovviamente da quanto siamo capaci di essere incisivi nel modificare lo status quo. E da quanto siamo determinati a farlo.
La cultura aziendale non è esente da questa reciproca influenza. È ovviamente in grado di condizionarci, sempre che esprima princìpi in linea con i nostri. Ma ci lascia anche la libertà di agire, qualora sentissimo il bisogno di creare piccole oasi nelle quali rifugiarci.
Non è insolito trovare delle sottoculture all’interno delle aziende, ossia culture che si sviluppano fra persone che hanno caratteristiche in comune.
Ad esempio l’appartenenza alla stessa unità organizzativa, o la condivisione dello stesso obiettivo (come lavorare presso lo stesso cliente), o del medesimo interesse (come praticare uno specifico sport insieme).
Le sottoculture non vanno necessariamente contro la cultura dominante, ma possono avere princìpi in grado di coesistere con gli altri. La convivenza di diverse sottoculture può essere incoraggiata dall’azienda, quando è disposta a riconoscerne la forza creativa. Essa verrà però osteggiata se una delle sottoculture dovesse risultare di impedimento alla formazione di un clima adeguatamente collaborativo. Ciò è necessario al raggiungimento degli scopi aziendali.
Un esempio famoso di sottocultura creativa è quella che John De Lorean introdusse nella linea produttiva della General Motors, prima di uscirne per creare la propria casa automobilistica. L’originalità fu tollerata dalla dirigenza sia grazie alla personalità di De Lorean, che lo rendeva molto popolare, sia grazie alla consapevolezza che il profitto non ne avrebbe risentito. Au contraire…
Bibliografia:
Mary Jo Hatch, “Teoria dell’organizzazione”, Terza edizione 2013, casa ed. Il Mulino
Francesco Avallone, “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”, 2011, Carocci editore.